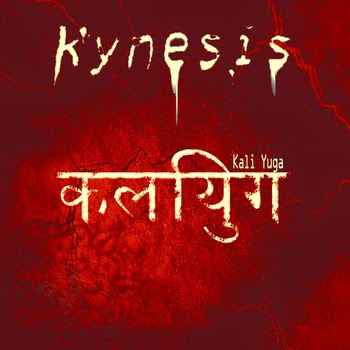ALLA RICERCA DELLE FOGLIE DI CASTEL DEL RIO
(Parte 1 di 2)
Poco. Ho dormito davvero poco, eppure mi sento talmente tanto pronto che riesco a destarmi in anticipo rispetto alla sveglia che, come da programma, alle 06:30 in punto suona.
L'odore del caffè appena fatto è un dolce compagno di risveglio, così come la ciambella che lo accompagna. Il pranzo al sacco è pronto, il mio fedele zainetto Newfeel mi osserva da dietro la porta. In più, per una volta, ho deciso di concedermi il lusso del borsone frigo, già riempito di bottigliette d'acqua e succhi di frutta.
La notte appena trascorsa è stata calda, in linea con la stupida stagione che sta attraversando tutto il paese: perciò, mi limito a prendere una felpa con la zip. Come si dice dalle mie parti, "meglio ave' paura che buscanne".
Il primo appuntamento è con Pippo, alle ore 07:30, praticamente di fianco a casa, visto che abitiamo nella stessa via. Anche lui ha dormito davvero poco: ha tirato a far tardi al Papillon di Monteroni e , come mi racconta, non ha avuto neanche il tempo di fare colazione. Prometto che ci fermeremo ad un bar quanto prima. Claudio, l'altro appassionato compagno di viaggio, è invece più fresco e riposato: la sera prima ha fatto il bravo, non ha bevuto ed è andato a letto relativamente presto. Lo invito a caricare il suo zaino nel portabagagli della Octavia e inizio a pubblicizzare la mia idea di portare il borsone frigo come un'intuizione assolutamente geniale che salvaguarderà il nostro pranzo e le nostre bevande.
Imbocco l'Autopalio e in mezz'ora siamo a Firenze, ancora assonnata e immersa nel grigiore umido e afoso di una domenica mattina. I semafori di Piazza Ferrucci sono tutti verdi, e collegarsi ai viali di circonvallazione è un attimo. Quel poco traffico che c'è si fa più rarefatto man mano che ci distanziamo dai viali e ci avviciniamo alle colline subito sopra. E' una parte della città che conosco bene perchè la mia famiglia viene da qui. Mio nonno è nato dalle parti di viale Righi e cresciuto in via del Salviatino. Inoltre, quando ero piccolo e il caldo in città diventava insopportabile, lui e nonna caricavano me e mia sorella sulla loro Alfa 75 e ci portavano a passare i pomeriggi in collina.
Arrivati a Fiesole scolliniamo e procediamo in direzione Caldine, attraversiamo la frazione di Olmo, e poi da lì ci dirigiamo verso Borgo San Lorenzo.

Sono quasi le nove e, salvo qualche sporadico raggio di sole, non si riesce ancora a capire che tempo sarà: a San Piero a Sieve sembra di essere tornati indietro di un paio di mesi, mentre a Firenzuola si respira l'aria (ben più ragionevole) di pieno autunno, con tanto di meravigliose foglie morte a bordo strada e l'odore di castagne provenienti dai boschi che costeggiano questa strada antica e anche un po' selvaggia.
Giunti al Passo del Giogo, che sorge a ottocentottantadue metri sul livello del mare, facciamo scalo: non sono neanche le dieci, Pippo necessita di fare la sua colazione, mentre il mio corpo implora l'assunzione di un secondo caffè. Sulla terrazza panoramica che si affaccia sulla vallata circostante, un paio di famiglie attendono il proprio turno per mettersi in posa e scattare foto, mentre tre motociclisti si stanno rimettendo in testa i caschi e si dirigono verso le loro Guzzi lucide e possenti. Penso fra me e me che non solo non capirò mai niente di motociclette, ma che le
custom in particolar modo proprio non mi piacciono. Una volta dentro all'albergo ristorante bar Il Giogo, ordiniamo, e ho modo di fare immediatamente caso al mutare della parlata, che risulta, almeno qui, un bizzarro incrocio fra fiorentino e romagnolo. Per me, un caffè ristretto, mentre per Pippo cappuccino e fetta di crostata; panino con finocchiona e pecorino per il ben più temerario Claudio. Esco a prendere la macchina fotografica e mi soffermo a guardare la nebbia che va a scendere, infittendosi, fra gli abeti della valle. I motociclisti se ne sono andati e le famiglie si dividono, chi prosegue verso l'Emilia Romagna, chi ridiscende in direzione di Scarperia. C'è odore di autunno, nell'aria. Di autunno e di nicotina: infatti, mi volto in direzione dell'albergo e noto un uomo di mezza età dalla carnagione rossastra intento a sorseggiare, da un bicchierino, una bevanda di colore scuro e ad aspirare grandi boccate da una Diana rossa. Mi guarda come i messicani degli albi di
Tex guardano i forestieri appena entrati in città col cavallo sudato e ancora addosso la polvere della prateria. Rispondo con indifferenza alle sue occhiate sospettose e annuncio che faremo qualche fotografia e ripartiremo subito dopo.

La discesa verso il confine comincia rapidamente, e, passata Firenzuola, imbocchiamo la statale Montanara Imolese, e cioè quella strada che dovrebbe condurci a Castel del Rio attraversando la Valle del Santerno, meravigliosa e sovrastata da una gigantesca palla di sole. Trascorrono minuti senza imbattersi in altre automobili e la pace regna sovrana, interrotta solo dalla corrente del Santerno. Dall'abitacolo dell'Octavia, osserviamo frazioni che si susseguono, minuscoli centri abitati fermi nel tempo che fino a poco tempo fa erano riuniti nella Comunità montana Valle del Santerno, fatta sciogliere, tramite una delibera della regione, nel 2009. Mi colpiscono i giardini delle case, curati e spesso arricchiti da mezzi agricoli e vecchie altalene in plastica o ferro battuto; sui vialetti, auto italiane sfoggiano ancora le targhe nere con scritta gialla. La strada prosegue e l'Emilia Romagna si avvicina.
Con Pippo e Claudio, parliamo della Linea Gotica e del fatto che la guerra qua è stata davvero terribile, specie per i civili. Racconto del circolo ARCI di un paesino mugellese e di come il gestore, un ex-partigiano, avesse deciso di apporre all'entrata un cartello recante la scritta "Vietato l'ingresso ai tedeschi". Dopodichè, la nostra attenzione viene attratta da una piccola chiesetta posta in prossimità di una curva a gomito: ci sono diverse macchine parcheggiate là attorno, e un bel po' di attempati fedeli stanno uscendo. La messa è finita e l'auto diventa immediatamente il luogo di frettolosi pensieri
pro e
contro i riti sacri e le tradizioni. Vorrei tanto convincermi che partecipare alla funzione aiuti e faccia vivere meglio gli ometti che stanno uscendo, sorridenti, da quel portone vecchio quasi quanto la valle, ma l'unica cosa che mi viene in mente è il personaggio di Rust Cohle, specie quando in uno dei suoi straordinari monologhi spiega che- secondo alcuni antropologi -la religione è un virus del linguaggio in grado di riscrivere i percorsi del cervello e di offuscare il pensiero razionale. Sono d'accordo con lui.
Ci distogliamo dal filosofare solo quando i nostri occhi incrociano una grande barra rossa che taglia, in diagonale, un cartello su cui sta scritto "Toscana": siamo ufficialmente in Emilia-Romagna, e il primo comune in cui ci imbattiamo è proprio la meta del nostro viaggio, Castel del Rio.
 |
| Il Ponte Alidosi in una tavola de La compagnia della forca |
Questo paese di neanche milletrecento abitanti vanta radici piuttosto antiche: i celti si insediarono sul territorio in cui sorge oggi già nel VI secolo a.C., e i romani vi costruirono un
castrum durante l'età di Cesare. Vale la pena specificare, però, che l'antica Castel del Rio non era stata edificata esattamente dove si trova il paese oggi e non portava questo nome, bensì quello di Mercatale, in quanto borgo che i feudatari di allora, gli Alidosi, avevano predisposto al commercio. Dopo il terremoto che spazzò via la vicina Massa di Sant'Ambrogio (oggi Montefune), Mercatale visse una stagione di ripopolamento e divenne uno dei centri più importanti della zona, assumendo solo in seguito il nome di Castel del Rio. Quelli del XVI secolo furono anni prosperi e coincisero con la costruzione delle grandiosi opere che tutt'oggi abbelliscono il paese: dall'omonimo Palazzo (oggi sede del municipio e cuore del Magnus Day) al celeberrimo Ponte, dichiarato monumento nazionale già da Vittorio Emanuele II e immortalato più volte da Magnus nelle tavole de
La compagnia della forca.
 |
Il Bernabei, organizzatore del "Magnus Day",
con Vittorio Giardino e il piatto da lui disegnato. |
Trovo parcheggio nei pressi di una schiera di villette moderne. Non appena scesi, percepiamo che è un caldo irreale e prepariamo gli zaini, che ci dovranno stare sulle spalle per buona parte della giornata. Raggiungere Palazzo Alidosi è un attimo e notiamo un viavai continuo di gente di ogni età. Ovviamente, non tutti si sono appassionati ai fumetti, e le attrattive di Castel del Rio sono di tutt'altra natura: mi riferisco alla celeberrima Sagra del marrone, giunta alla sua cinquantanovesima edizione. Eppure, può sembrare incredibile, ma anche una fiera gastronomica qua finisce col godere di un legame forte col mondo delle nuvole parlanti. Nel 1995, infatti, fu proprio Magnus a disegnare il piatto celebrativo che, tutt'oggi, continua ad essere creato dai giganti del fumetto: quest'anno è il turno di Vittorio Giardino, presente all'evento.
Ad accogliere i visitatori del Magnus Day troviamo due gigantografie ispirate a
Sturmtruppen e
Nick Carter, entrambe creazioni di Bonvi, che per un breve periodo raggiunse l'amico e collega Magnus qua sugli Appennini, allo scopo di tenersi lontano dai vizi cittadini e di lavorare più placidamente. Ma il vero punto-accoglienza della fiera è rappresentato dallo stand di tale Romeo Rensi, personaggio conosciuto da tutti in paese e grande appassionato di rally: ci racconta che col suo team di piloti amatori ha gareggiato fino al 2006, e ci mostra, inorgoglito, un disegno di Magnus accompagnato da una lettera. <<Magnus>>, ci spiega con un marcato accento alidosiano, <<io l'avevo sempre fra i piedi. Veniva a casa mia tutti i giorni, e spesso disegnava. A me i fumetti interessavano poco e ho perso il conto di quanti disegni gli ho strappato, dio... Comunque il logo della mia squadra di rally lo ha disegnato lui>>, e indica la caricatura di una macchina da rally sia sul foglio che su una vecchia maglietta rossa che ha addosso. Romeo vende di tutto: dai marroni, raccolti personalmente da lui, a vecchi numeri di
Tex fino ad una discreta quantità di materiale raro e introvabile riguardante Magnus. Durante la giornata, torneremo più volte a trovarlo e lui, sigaretta perennemente accesa fra le labbra e bicchiere di Trebbiano in mano, risponderà ad ogni nostra domanda con un'enfasi difficilmente riscontrabile fra le schiere di
nerd che, tristi ma pieni di sè, sovraffollano ormai quasi tutti gli eventi legati al fumetto.
%2Bvisto%2Bda%2BMagnus.jpg) |
| Castel del Rio vista da Magnus. |
Ma prima di accedere alla grande stanza dove il Magnus Day trova il suo effettivo svolgimento, veniamo avvicinati dal signor Franchini, proprietario della società viticola omonima e presente alla fiera per esporre i propri prodotti. La mia attenzione viene attratta immediatamente dalle etichette di un paio di bottiglie, disegnate ad acquarello e china con un tratto a me familiare: sono opera, infatti, di Sergio Tisselli, ora impiegato nel team di
Tex (la sua storia d'esordio esce fra meno di un mese) e ricordato per essere stato il disegnatore dell'unica opera in cui Magnus si occupò esclusivamente della sceneggiatura, e cioè
Le avventure di Giuseppe Pignata (pubblicato da Granata in tre albi, poi raccolti da Grifo Edizioni in un volume recente molto costoso). <<Volete fare un aperitivo, raga
ssi?>>, ci viene chiesto. Io guardo l'orologio: non è neanche mezzogiorno. <<Fra poco s'arriva!>>. Non è una bella cosa entrare nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi già mezzi sbronzi, o almeno non è cosa per noi.
Il Magnus Day è un evento patrocinato dal Comune di Castel del Rio, pensato e organizzato, a partire dal 2007, dall'associazione Gli amici di Magnus, a cui fa capo l'impagabile Gabriele Bernabei, appassionato, sceneggiatore de
L'Orso (disegnato da Tisselli) e autore del saggio
Il pittore di Castel del Rio (A&G Editore), libro che cerco da anni senza riuscire mai decidermi a comprarlo a causa del suo caro prezzo (su internet, le quotazioni oscillano fra i cento e i centoventi euro). A partire dal nome, nella Sala Magnus tutto è un sentito omaggio al Maestro: dai leggendari e meravigliosi portfolii realizzati da grandi autori del fumetto italiano (ben tre erano in vendita quest'anno) alle collezioni complete esposte sulle bancarelle. <<Cercava qualcosa in particolare?>>, possono chiedermi. <<No, grazie, ho già tutto!>>, sarebbe la risposta da parte mia. Ho impiegato circa due anni (dal 2004 al 2006) a raccogliere un buon novanta percento dell'opera omnia di Magnus, e posso garantire che portare a termine un'operazione di quel genere senza internet e, soprattutto, senza che le grandi case editrici avessero iniziato una riproposizione integrale dei fumetti più rari e antichi, non fu cosa facile, specie per me, all'epoca appena quindicenne e di certo non ricco sfondato.
In bella mostra, troviamo il piatto disegnato da Giardino, prodotto in serie limitata e autografato. Verrà presentato alle 15:00, nel corso della conferenza stampa che oltre ai già citati Bernabei e Giardino, vedrà coinvolti anche alcuni disegnatori presenti in fiera: fra gli altri Andrea Venturi, Giuliano Piccinino, Simone Cortesi (il suo
Aspettando il vento è fresco di pubblicazione, presso Becco Giallo) e Antonio Sforza. Non ci sono file e non c'è ressa: finalmente, una fiera-tributo a cui prendere parte placidamente e senza fretta. Alle pareti, svettano capolavori quali la copertina pastello della seconda edizione de
Le femmine incantate, tavole della
Compagnia della forca e dell'ancor più leggendario "texone". In fondo alla sala, col tacito accordo della Sergio Bonelli Editore, è stata allestita una micro-retrospettiva in cui vengono mostrate, in anteprima, diverse pagine del
Tex di Tisselli, in arrivo a novembre sul sesto ColorTex. Noto, con lieve rammarico, che almeno per ora siamo i visitatori più giovani della sala.
Visto che per il momento non sono previsti appuntamenti particolari, decidiamo di visitare il paese. Bancarelle di prodotti locali e giganteschi bracieri dove montanari nerobruti cuociono le castagne vengono intervallati da banconi che vendono di tutto e di più, dall'abbigliamento fino agli otturatori laser per pistole a pallini. Ai lati, scorre la vita della vera Castel del Rio, con i suoi ristorantini, le sue abitazioni, la sua chiesetta, i suoi bar. Abbiamo modo di ammirare il caratteristico Albergo Il Gallo, dove Magnus visse, in pianta stabile, per tutti e sette gli ultimi anni di vita; accanto, trova spazio il Ristorante omonimo, che per la serata ha organizzato un evento su prenotazione dal titolo "Cena d'Artista". Tuttavia, abbiamo già deciso con largo anticipo di non prendervi parti, dal momento che Castel del Rio e i suoi bei dintorni offrono- a detta di Tripadvisor -scelte gastronomiche superiori. Superata la piazza principale, la conformazione del paese assume, quasi impercettibilmente, forme più ripide. Ci ritroviamo così in una piazzetta dalle dimensioni più contenute e dall'aspetto più vetusto, e proprio qua, di fronte ad un garage aperto, alcune signore del posto sono intente a vendere dei marroni di bell'aspetto per sette euro e mezzo al chilogrammo. Pippo non resiste, e ne ha ben donde: dalle nostre parti, infatti, sono ormai due anni che le castagne sono divenute pressochè introvabili. E pensare che fino a poco tempo fa ero anche io uno di quelli che, nelle domeniche autunnali, prendevano la macchina e risalivano la Montagnola senese, zona notoriamente ricca di castagneti, per tornare a casa la sera con le dita ricolme di aghi ma il paniere zipillo.
 |
| Pippo e i marroni di Castel del Rio. |
Finito il giro, decidiamo di onorare l'invito del signor Franchini e torniamo sui nostri passi, verso l'ingresso. L'ora di pranzo si avvicina e la gente inizia a speluzzicare la schiacciata all'olio e a chiedere, in abbinamento, dei bei bicchieri di Sangiovese e Trebbiano. <<Io ve lo dico subito. Inizio a darvi da bere e ve lo do finchè non mi dite basta!>>, ci avverte il buon Franchini prima di passare a presentarci le varie tipologie di vino presenti. Partiamo col Sangiovese e ci addentriamo in chiacchiere riguardanti due delle dieci cose migliori al mondo: il vino e i fumetti. Non capita tutti i giorni, almeno a me, di incontrare persone con cui poter scambiare, in totale tranquillità, due parole su certi argomenti, senza dover per forza esagerare e fare la gara "a chi ce l'ha più grosso". Soddisfatti dei ripetuti assaggi del Sangiovese, semplice e aromatico anche se un po' troppo secco, optiamo per un Trebbiano, già stappato in precedenza. Mentre siamo intenti ad apprezzare questo vino decisamente più asciutto, interviene anche il mitico Romeo, con una
sua bottiglia. <<Avanti, facciamo un brindisi!>>, esclama Filippo. E così sia. Io, nel frattempo, inizio a trattare per ottenere un bello sconto sul libro di Bernabei, che Romeo tiene in numerose copie al suo stand. Me lo sfoglia pure davanti, facendomi patire come una bestia. <<Come ben sai, è fuori catalogo...>>, comincia. <<Vero, ma su internet se ne trovano tante copie a cifre vicine alla tua e ancora in busta>>, lo interrompo subito. Riesco a farlo scendere ad ottanta euro, sempre e comunque troppo per le mie tasche. Poi la conversazione si sposta sul fatto che
La valle del terrore è stracolmo non solo di ambientazioni appenniniche, ma anche di volti alidosiani, uno dei quali appartenente proprio al buon Romeo, le cui fattezze furono sfruttate da Magnus per un personaggio non di certo positivo: mi riferisco a Wong, il tirapiedi cinese di May-Lin. In effetti, ora che lo abbiamo di fronte e me lo immagino più giovane di venticinque anni, ho modo di apprezzare la somiglianza.
Alla fine, si è fatto tardi: l'alcool ci ha aperto lo stomaco e lasciamo, momentaneamente, la mostra per dirigerci verso il Ponte Alidosi, che si rivela subito all'altezza della fama che lo precede. Particolare, bellissimo, calato in uno splendido contesto e mantenuto magnificamente (l'ultimo restauro risale a tre anni fa), fu commissionato a tale Mastro Guerrieri da Imola nel 1499. Noi ci posizioniamo nel parco che trova spazio là sotto e apriamo gli zaini: panini, schiacciate, succhi di frutta e litri di acqua spariscono rapidamente, dopodichè cala, inesorabile, l'abbiocco. Ci teniamo svegli parlando del più e del meno, osservando con diffidenza le palazzine di recente costruzione che hanno edificato nei pressi della sponda sinistra del ponte.
 |
| Pranzo panoramico. |
Nonostante l'ombra, fa ancora caldissimo, e la tentazione di improvvisare un pellegrinaggio al vicino Santuario della Beata Vergine del sudore è forte. Per evitare di schiacciare un sonnellino (il che comporterebbe la perdita della conferenza stampa pomeridiana), optiamo per un caffè rigenerante ad un vicino chioschetto. Un babbo e un bambino, intanto, pescano sul Santerno, e alcune famiglie si affollano attorno alle griglie presenti lungo tutto il perimetro del parco. Iniziamo a fare il punto della situazione sul dove andare a cena la sera e alla fine optiamo per la Trattoria Damì, alla quale decidiamo di telefonare prima possibile perchè dicono essere sempre piena di gente, specie nei caldi fine settimana della valle. Il 3G non prende lungo il Santerno e proviamo a ricorrere ad antiche metodologie. Di fatti, avvicino il barista che ci ha serviti e gli domando <<Avete un elenco telefonico?>>. <<No, mi spiace...>>. Confidiamo che i nostri
smartphones tornino a prendere campo non appena saremmo risaliti verso il paese.
(Continua...)






%2Bvisto%2Bda%2BMagnus.jpg)